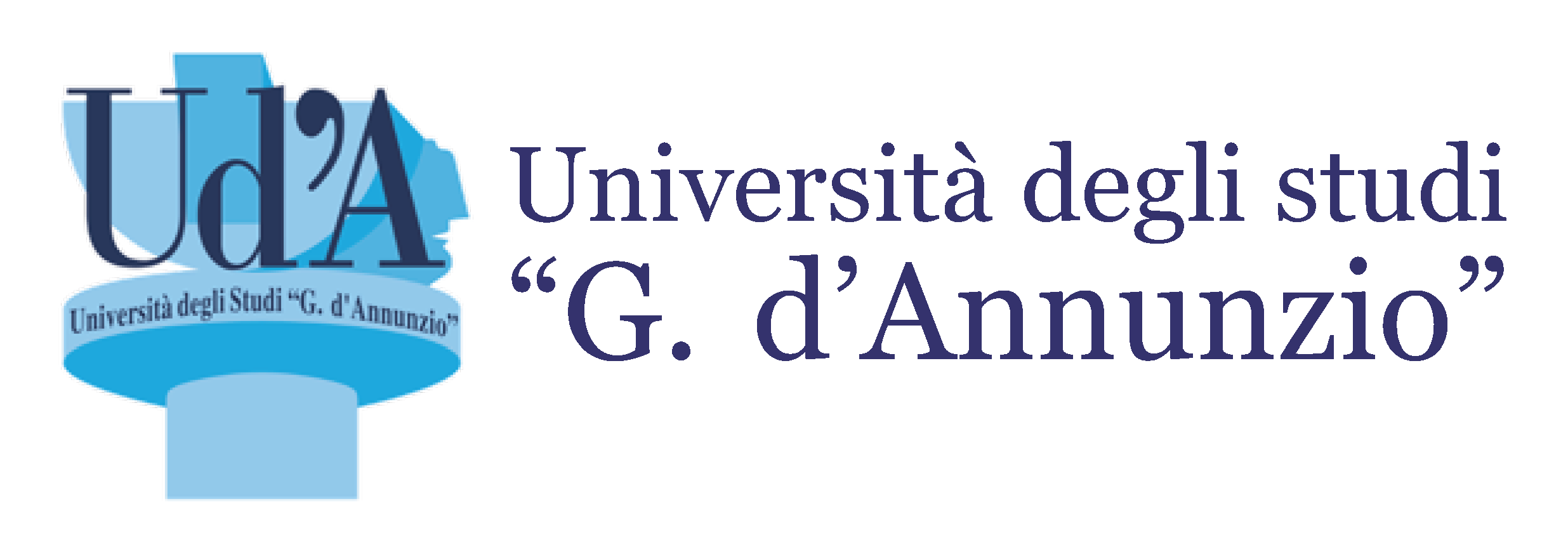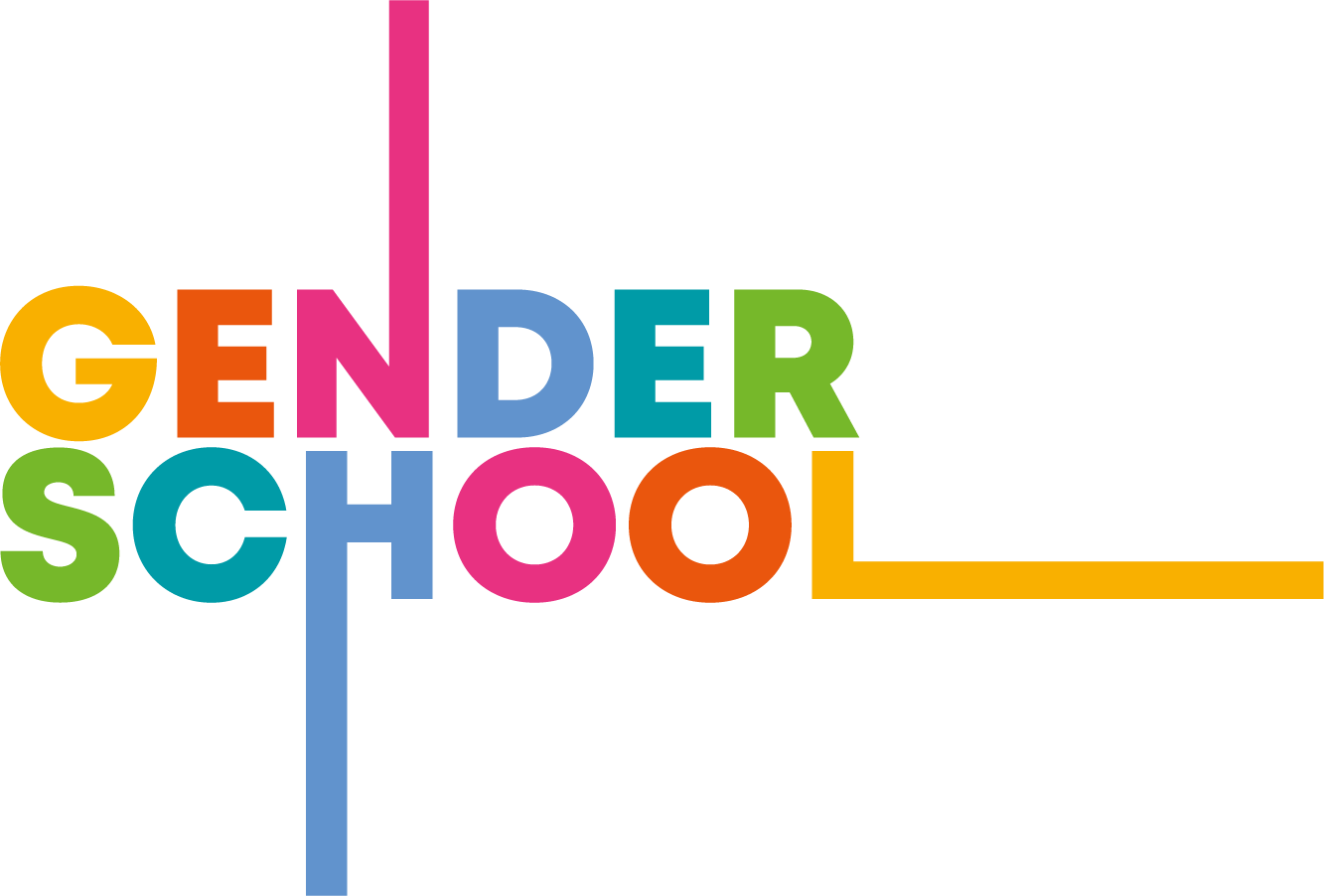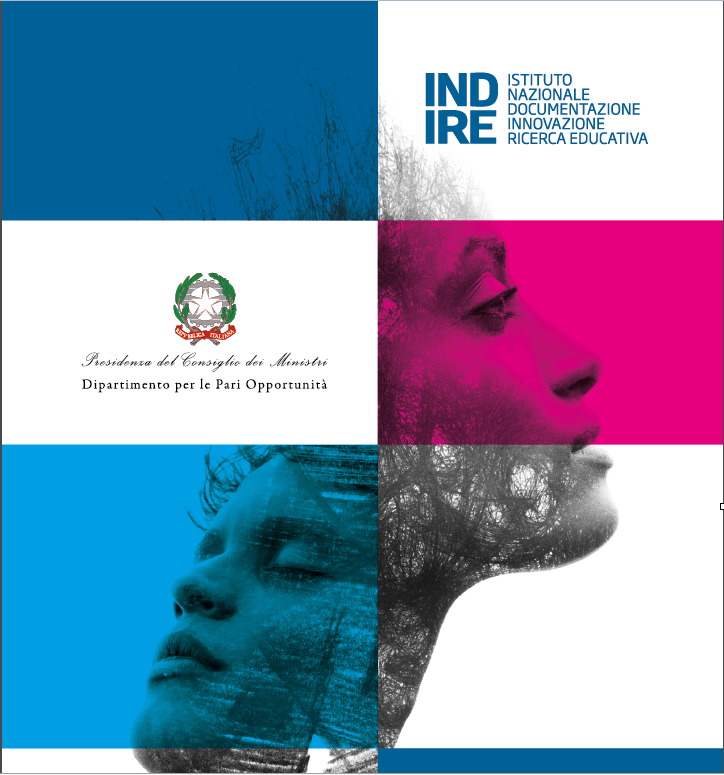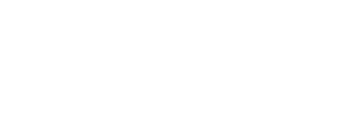Rubrica di letture e altre narrazioni ai tempi dell’emergenza
di Fausto Benedetti, Patrizia Garista
L’emergenza sanitaria ha indotto e costretto molte persone all’interno della propria abitazione e del proprio contesto familiare, creando non poche difficoltà nella frequenza alle normali attività scolastiche o altri tipi di complicazioni nella conciliazione dei tempi di cura tra casa-lavoro.
In questa emergenza molti temi affrontati all’interno del progetto Gender school, che riguardano il contrasto alla violenza di genere e ad altre discriminazioni, sono riemersi come bisogni a cui dare urgentemente risposta da un punto di vista educativo.
A partire da questa prospettiva la Rubrica di letture e altre narrazioni intende offrire alle famiglie, agli educatori e agli insegnanti, degli spunti per continuare ad accompagnare la costruzione di fattori protettivi nella relazione e nel lavoro educativo, resistenti alla violenza di genere.